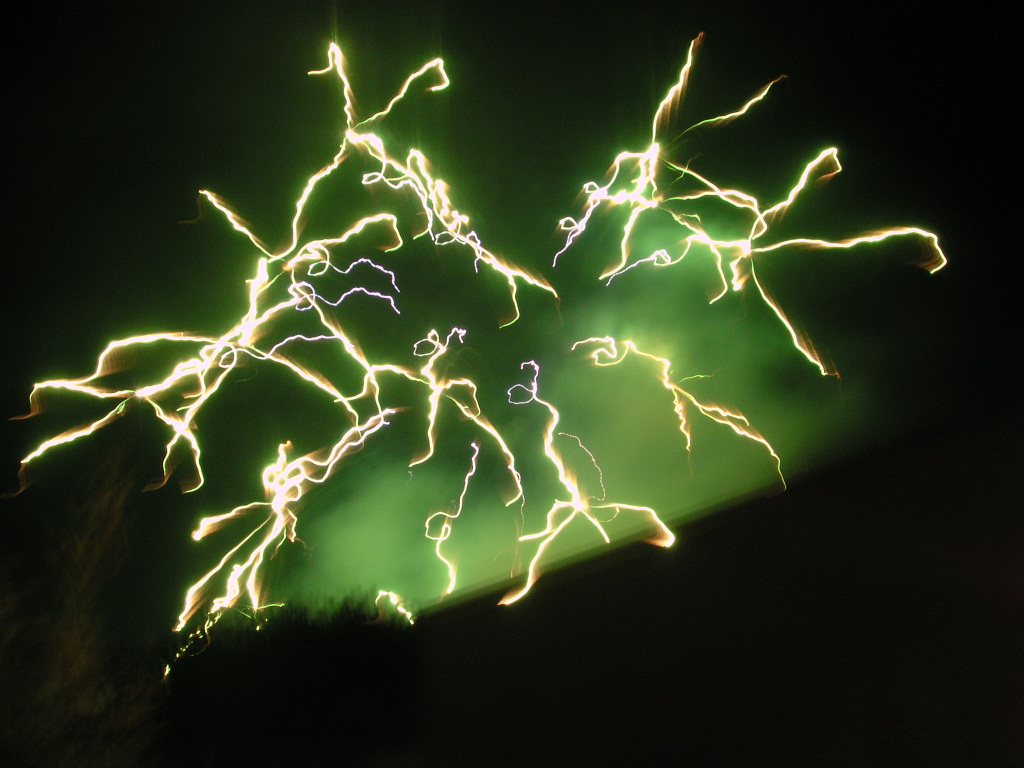Prima dell'operazione non sapevo se sarebbe rimasto in laparoscopia (tecnica meno invasiva in cui fanno dei buchetti nella pancia (a me 4), uno sopra l'ombelico da cui entra una micro videocamera; uno dal lato da cui aspirano, tagliano, operano, tolgono pezzetti di carne, mettono punti; l'altro dal lato opposto, da cui drenano con un tubo il liquido che, insieme all'aria, immettono nella pancia per lavare e separare organi e tessuti interni mentre lavorano, e vabbè un po di sangue, che quello scorre lì dentro) o se avrebbe dovuto tagliare proprio la pancia, togliere tutto. Il proff. mi aveva avvertito, settimane fa, io per tutto il tempo ho sperato sempre nella prima opzione, ma ero preparata anche alla seconda.
Non mi sono resa conto di essere arrivata in sala operatoria fino a che non hanno iniziato le manovre per l'epidurale. Dalla camera dove sono stata prima e dopo, ci sono arrivata a piedi in sala operatoria, niente sedie niente barelle, con uno degli assistenti giovani che mi era venuto a prendere; pensavo, speravo, fosse qualche altra pre-analisi (anche se era una chiara rimozione, insomma, mi (ri)preparavo da giorni tra purghe e digiuno e sapevo che la mattina sarei stata la prima). Mi sono messa io il camice verde di carta addosso (stavolta dritto, cioè storto), raccolto i capelli nella cuffietta, ma non avevo davvero capito che ero già li, finché sott' occhio non ho visto da un lato tutti quei monitor e apparecchiature e mi sono resa conto che c'erano delle luci al neon fortissime, troppo, che sparavano dal soffitto. Uh cazzo ci siamo, mi sono detta. Poi è diventato tutto improvvisamente veloce, mi hanno fatto sedere su quella che in qualche secondo ho capito che sarebbe diventato il mio "tavolo operatorio" e, da seduta, mentre mi spiegavano in che posizione stare - metti le braccia tra le gambe, piegati un po' in avanti, stai rilassata - e io dicevo - scusate, sono un po' emotiva - ma in realtà ero più frastornata dall'aver capito che c'eravamo, pronti, partenza... mentre mi pungono la schiena in basso una voce (l'anestesista) dà indicazioni brusche sulla posizione - dell'ago penso io - e una donna esegue, risponde "come storto? così?", io penso ma vedi a questa che impara addosso a me, ma sento solo una strana pressione, e infondo andiamo Simo, sei agofobica è vero, ma poi stai piena di tatuaggetti, essú, e mentre io appunto biascico tragica "ho un tatuaggio sulla pancia se dovete tagliare, tagliate, è il primo, è tutto sbiadito..." la voce dice "senti il caldo nelle gambe?" e io "no", "come no?", "...ah...si...comincia, la destra". Intanto intorno ti si muovono varie persone indaffarate, almeno quattro, cinque, che ti fanno cose (un dito in una pinzetta, prove di pressione), ed alla fine, per ultimo, tipo rock star, entra lui, il chirurgo (ho visto dei top back stage e vi assicuro che il paragone è calzante). Sotto la mascherina la cuffia e il camice io non lo avevo riconosciuto, ma mi saluta guardandomi un secondo negli occhi, e chiamandomi per nome "... 'giorno Simona", e allora ho ricordato lo sguardo verde cupo che mi aveva colpito quando lo avevo incontrato alla prima e unica visita fatta con lui, e ho detto, o forse ho pensato, stupita, quasi felice "uh eccolo!" mentre mi tocco la gamba e penso che mi avrebbero potuto prendere a forchettate nelle cosce e non avrei sentito nulla. Me le hanno alzate sulle sbarre tipo visita ginecologica perché ho detto che non potevo più muoverle io, che sensazione strana, e poi mi hanno attaccato delle cose gommose al petto, strappato in due il camice verde, stesa, e una voce ha detto fai un bel respiro, mentre mi mettono una mascherina che caccia fumo bianco e fresco sulla faccia.
Mi sono risvegliata dopo quelli che sembrano essere pochi secondi, ma in realtà sono circa tre ore, con la voce che mi chiamava da lontano "Simó come và?" e io "bene tutt'apposto", "ah vedi mi senti pure da qua brava". Il botta e risposta con l'anestesista mi ha fatto svegliare del tutto, completamente e in un secondo, no dolore ma consapevole: sono stesa, fuori il corridoio delle sale operatorie, con i medici che continuano con la successiva (la mia compagna di stanza, una ragazza più giovane di me, alla 4 recidiva, che mi ha aiutata un sacco, lei a me, una forza della natura in uno scricciolo di femmina ❤️), le luci fortissime e l'istantanea percezione di aver tutto in un secondo presente quello che è successo. Non ho mai sento davvero dolore (sono attaccata ad uno stupefacente palloncino trasparente dentro una teca di vetro di toradol e morfina che durerà tutta la giornata e tutta la notte, man mano lo vedi che si sgonfia), ma "sento" i buchi nella pancia gli aghi nelle vene le gambe ancora formicolanti, anzi non "lo sento", lo so, me ne rendo conto, e quindi comincio a respirare un po' veloce, iperventilazione, no simo, il panico ora no, l'anestesista si accorge subito e viene vicino a me, si fa vedere, mi dice Simò tranquilla… respira piano… hai fatto… tutto apposto… e io eseguo. Ogni tanto lui ripassava a controllare, a un certo punto ho chiesto "mia madre?" E lui ha detto sta fuori, come si chiama, glielo dico che sei sveglia. Sono stata circa due ore, forse di più, parcheggiata fuori alla sala operatoria sotto controllo, mentre mi svegliavo. Poi mi hanno riportata in barella in camera, ho visto mia madre e ho pensato 'grazie' , e poi 'bravissima' , aveva la faccia preoccupata e le ho detto sto bene, ed era vero. Mi hanno spostato dalla barella al letto e ti ritrovi per 24/36 ore circa (se tutto va bene, ed è andato tutto bene) stesa immobile con due aghi nelle braccia un tubo nella fica e uno che esce dalla pancia e drena i liquidi, con gli infermieri che ogni tot vengono e ti iniettano cose bucano mani braccia, fattissima e tranquilla, nulla importa oltre al fatto che é passata, andata. Un po' di dolore al petto per il washing peritoneale.
Dopo la carne e il sangue, l'attesa che chiude il cerchio è, ovviamente, la merda, siamo fatti pure di questo: la "canalizzazione", cioè il passaggio dell'aria (perché la cacca in realtà ce ne vuole un po di giorni, diciamo una settimana) da dentro a fuori attraverso l'intestino, diventa fondamentale (la mia amica pediatra giustamente mi ha detto "pensa le feste quando i bimbi fanno la prima cacchina!"). Solo dopo sta cosa ricominci a riprendere pian piano l'uso autonomo degli organi del ventre, ti staccano l'idratazione artificiale, ricominci pian piano a mangiare quello schifo delle mense degli ospedali pubblici, dopo 48 a bere, a succhiare caramelline alla stevia che sanno di paradiso, ti staccano il catetere e ti alzi piano piano, rotolando, attenta ai fili, per andare in bagno trascinando sta sacca di liquido che hai attaccata alla pancia con un tubicino, io ci ho anche preso il caffè alle macchinette e fumato mezza sigaretta 😈) e poi quando smetti di spurgare per bene (diciamo 3-4 giorni) tolgono anche sto tubicino (ho riempito di complimenti l'infermiere che lo ha fatto, poco dopo averlo trattato malissimo perché aveva detto te lo tolgo e domani ti dimetteranno, e io COME DOMANI OGGI, PARLO COL PROF! STO BENE ME NE VADO, non posso firmare io qualcosa…) e il tubino a farfallina che hai nel braccio per 4-5 giorni da cui ti iniettano i medicinali.
In tutto questo sul piano nascevano bambini - almeno una decina in due tre giorni, vari gemelli, e una notte di trambusto (la seconda dopo l'operazione) per un sospetto caso di covid. Nessun parente o amico può entrare (la prima notte mia madre, con sierologico) quando mi hanno dimessa (visita, emocroma stacca cerotti, togli aghi, foglio delle cure) ho chiamato casa "lo so che piove a dirotto, ma mi venite a prendere?" e quasi piangevo di gioia. Mi sono fatta la valigia con le mie cose da sola, lo zainetto, mi sono messa gli occhiali da sole anche se fuori pioveva ancora e salutando gli infermieri, ringraziando le dottoresse, me ne sono uscita così, tirandomi il trolley. Come se stessi andando a imbarcarmi per delle meravigliose vacanze
P. S.
Fate prevenzione, andate nei consultori, non sottovalutate gli sbalzi del ciclo, i dolori strani, io mi sono accorta di avere sto robo per i controlli che faccio al consultorio pubblico ogni tot, pensavo fosse colite, congestioni, invece era una pallotta molla trilobata di quasi 12 cm cresciuta in meno di un anno che tra un paio di settimane saprò bene di cosa precisamente era fatta.