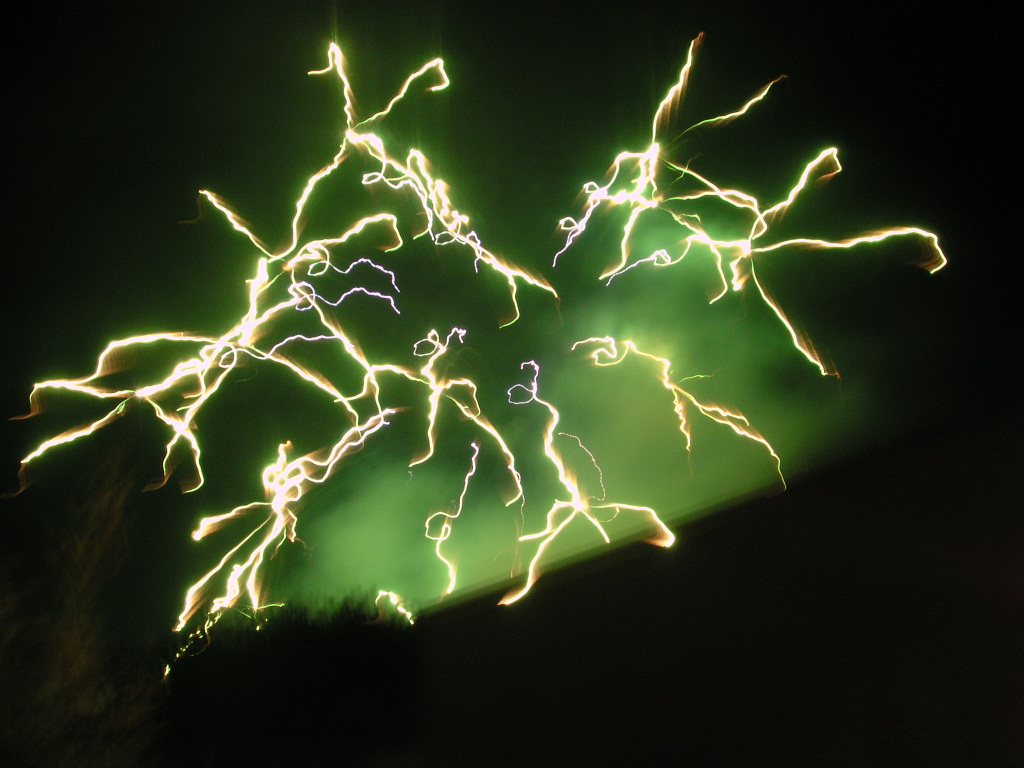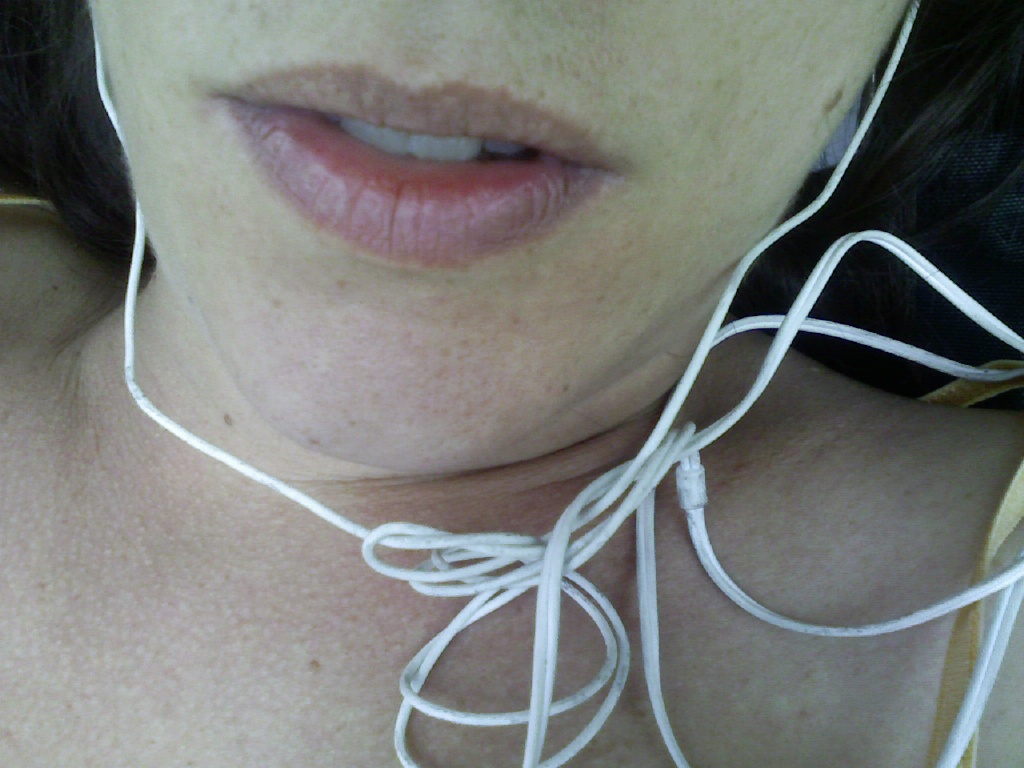La maggior parte della gente è convinta che la moda sia qualcosa di fondamentale; la verità è che le creazioni degli stilisti, sui loro begli ometti, sono nient’altro che abiti. Stoffa cucita insieme. Anzi, quelli di marca, da sera, appena li togli dalla stampella, diventano inconsistenti straccetti, li prendi tra le mani e non capisci più qual'è il sopra e qual'è il sotto, il davanti o il dietro; e poi, inutile dire, sono cari, oltre ogni ragione. Giustificherei più facilmente il prezzo se gli abiti fossero realmente frutto di creatività superiori, opere d'arte, ma quelli che finiscono in vetrina sono ciò che resta dopo le bieche previsioni di vendita e il pollice in su delle più famose boutique sparse qua e là per il bel mondo. Quelli che sfilano, mica li vedi, nei negozi.
L’evanescenza e lo scintillio, che genera invidie e stimola desideri, è così sbrilluccicoso che impedisce la vista.
Intanto orde di creativi in erba, potenzialmente innovativi, faticano a trovare stages non retribuiti.
Molti dei capi realizzati nella pre-produzione, quelli che fans e clienti vedranno sfilare, sono annullati perché non si venderanno mai. Solo quelli che hanno un mercato sicuro, quelli in pratica già venduti, sono mandati in produzione, e non importa quanto difficile e costoso sia realizzarli o se bisogna scuoiare ignare foche dei mari del nord per il collo e i polsi.
Quando lavoravo a Milano mi sono infiltrata a qualche defilè ed ho lavorato in un famoso atelier, di cui non farò il famosissimo nome, tanto uno vale l'altro. Zona Brera. Una quantità di spazio in affitto nel quadrilatero d’oro della città, a cifre esorbitanti per centimetro quadro. Niente, nonostante il pauroso giro di soldi e l’apparenza, che storicamente inganna, non riesco a considerarla una “cosa seria”. Questa macchina stagionale ed eterna che macina centinaia di assunti a tempo determinato per alimentare analisi di mercato e di “stili di vita” vuole imporre a me, imporre dico, qualcosa che dovrebbe essere libera espressione dell’individuo. Qualcosa che fa la sua porca figura solo quando scivola via a terra e ti lascia nuda come mamma t'ha fatto.
Chiariamoci, i vestiti mi piacciono e sono anche abbastanza vanitosa. Ma se adesso faccio fatico a trovare stivali neri semplici, no bucati, no frange, no con kilometri di finta nappa attorno, perdonatemi, ma andrò scalza.
I fashion victim, li sentite quando parlano? È tutto un “Caaraa beeella” strascicato con tono mellifluo e ascendente che sturba immediatamente le terminazioni nervose. Una profusione di teorie sulla moda che “...in se non ha più niente da dire” e sulla “donna che deve re-inventarsi quotidianamente, essere allusiva, concreta, vitale” e via con sequele di aggettivi infilati a caso, senza senso, uno dietro l’altro. Chi sa perché gli stilisti si lamentano dell’omologazione, ma continuano a produrre in serie. Imitarli, per alcuni, è l’unico modo per sopravvivergli.
Mi ricordo che da bambina avevo un incredibile passione per le Barbie e facevo abiti fatti da me, riciclando pezzi di stoffa e riadattandoli per la biondina coscia lunga. Stare nel backstage di una sfilata è come cadere nel cestone delle barbie. Bellezze in (poca) carne ed (evidenti) ossa, sempre livide di freddo, spogliate e rivestite in continuazione, fino a che la pelle non è arrossata dalle stoffe rigide, lampo e ciappette metalliche, clips e miriadi di bottoncini di vestiti che indossano centinaia di volte, ma che non saranno mai loro. La taglia è più o meno standard: “40” da collezione si chiama. Praticamente una 38, quasi 36, misure da bambina.
Le ho viste tante volte scherzare nei camerini, con l’accappatoio e le ciabatte ai piedi, come in un qualsiasi spogliatoio di una palestra. Nei sogni di uomini e donne diventano oscuri oggetti del desiderio, corpi da emulare; per le agenzie sono manichini viventi, e loro lo sanno.
Attorno bazzicano pessimi personaggi, qualcuno lavora, molti sembra che non facciano assolutamente nulla, altri si lamentano addirittura di essere tra bambole e champagne, anche se si vede lontano un miglio che l’orgoglio gli fuoriesce da ogni poro della pelle.
Quelli dell’amministrazione pensano solo “La sfilata è andata, migliaia di euro per una manciata di secondi, ma tutti ne stanno scrivendo”. Quelli dell’ufficio stampa hanno l’aria stanca e le borse sotto gli occhi per le nottate insonni passate a decidere chi far sedere dove e vicino a chi. Ma la cosa più importante è piazzare la collezione sul mercato, strizzare la gallina dalle uova d’oro. La campagna vendite! E’ il momento delle eleganti donne in tailleur divisa, gentilmente offerto dallo stilista mandatario, che le sguinzaglia all’impazzata. Sono loro, le “venditrici”, agguerritissime ed agitate arpie, mani in pasta di un uomo che, nel suo stesso tempio, concede udienza davvero raramente. Non fatevi abbindolare dalla loro aria blasée, sono commesse d’alto bordo. Man mano che aumentano gli appuntamenti con i clienti, calibreranno simpatie ed antipatie sulla base di incomprensibili equilibri. Niente per niente, tanto ci sono modelle e stagiste, per sfogare frustrazioni e vecchiaia che avanza. L’importante è il fatturato, il resto della macchina va avanti da sé.
Runner e facchini, nascosti agli sguardi dei clienti, continuano a sgobbare come pazzi, fieri delle loro belle magliettine made in Taiwan con su la “firma” dello stilista. Le sartine seguitano a cucire nei sotterranei. Gli abiti-prototipo, la “collezione” insomma, è rammendata continuamente, il che mi fa nascere interrogativi sulla qualità della merce in questione. Per controllare un bottone o riattaccare un’etichetta ad un abito le povere donne devono chiedere a qualche hostess di andare a prenderglielo, perché non si possono avvicinare agli abiti in esposizione, quasi fosse lo Spirito Santo ad averli cuciti, e non loro.
Dopo questo mese lo show-room tornerà ad essere un megaguardaroba per starlette della TV, che andranno di persona, o manderanno costumiste e “consulenti d’immagine”, a scegliere mise da indossare in trasmissione.
Per adesso è quello che è, una fucina di soldi e chiacchiere, con la competizione, negli appositi salottini, spinta ai massimi livelli.
I clienti sono da convincere e conquistare a tutti i costi, anche se spesso incompetenti e decisamente grossolani. Infondo cosa ci si aspetta dai commercianti? Se ne può parlar male solo quando non ti vedono.
“Caffè?”
“..caffè…”
“pasticcini?”
“..pasticcini…”, una profusione di sdolcinatezze; ma la linea che separa la cortese ospitalità dal servilismo ipocrita quì è scomparsa.
Ovviamente di soldi neanche l’ombra; euro, sterlina, yen o dollaro che sia, il denaro non si vede. Quando si fa “l’ordine” si arriva determinati al budget senza batter ciglio.
I soldi sono volgari, eppure sono qui per questo. Uno solo di questi semplicissimi pantaloni cammello non costa meno di duemila euro. Prezzo che sarà ricaricato per lo meno del 300%.
Cominciano ad arrivare arabi e giapponesi. Sono loro quelli che spendono le cifre più alte per portare il “Made in Italy” all’estero. Accontentiamoci, grazie a loro l’Italian style è famoso nel mondo.
Allestimenti mastodontici, colonne greche in cartongesso, ori e velluti a profusione, musica in sottofondo (gli stessi due pezzi colonna sonora della sfilata, mandati a ripetizione tutto il giorno, tutti i giorni).
Silenziosi e solerti camerieri si nascondono dietro le tende pesanti.
L’atmosfera è lussuosa ed ovattata, con le pareti tappezzate di abiti e scarpe, borse e occhiali, accessori multiuso tutti della stessa gamma di colori.
Nessuno si vestirebbe mai così, mi dico speranzosa, ma più mi guardo in giro più mi accorgo di sbagliare.
E se quest'anno si porta nero, grigio topo da giorno, grigio merda da sera scordati un vestito colorato.
E le luci, avete presente? le luci sono ovunque, sparatissime, 24oresu24. Riscaldano come tanti piccoli phon creando un ecosistema malsano e finto, come i sorrisi e gli occhi di tutti quelli che incontri, sparati e lucidissimi. Attraversano i corridoi moquettati a testa bassa, con aria fintamente affaccendata, vestiti di lucido nero impeccabile, seguite dal loro codazzo di assistenti, anch’esso rigorosamente in black con quell’aria sempre un po’ corrucciata, di chi si prende troppo su serio, sembrano irrequieti branchi di Labrador.
Anche io mi vesto di nero a volte, ma il mio è ombroso e macchiato di fumo.
In questi ambienti, se non dimostri qualcosa, qualsiasi essa sia, nessuno ti trova interessante.
Sei un copy? Un sound designer? Una stylist? Sai parlare l’inglese, usare il computer? Guadagni bene? Hai abbastanza contatti? Sei creativo, hai capacità di problem solving? Sei maturato in questi anni? Fatto esperienze all’estero?…
Mi sono chiesta se ne valesse la pena. Non mi piace l’ipocrisia e non m’interessa far finta, e so che il mio animo irrequieto non si calmerà grazie ad un vestito in più.
C'è più gusto a boicottarla, la moda, che a seguirla.