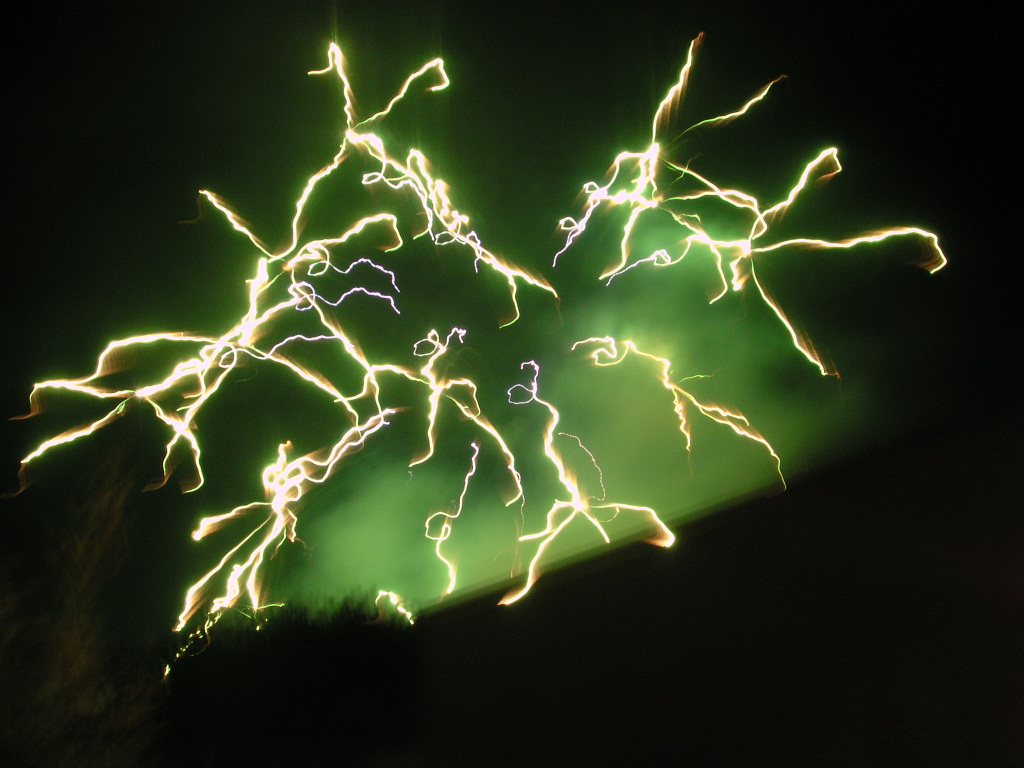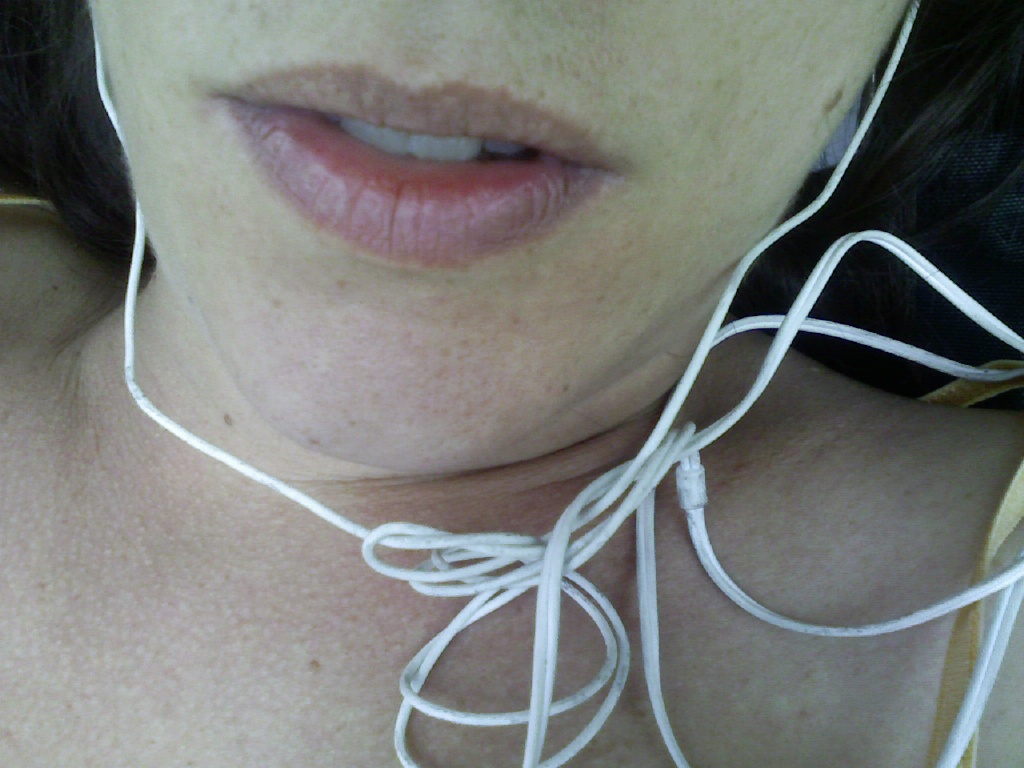Napoli, 1947.
I binari di piazza Garibaldi sono ricoperti di macerie, le rotaie distrutte dai bombardamenti, i detriti accumulati negli angoli a formare colline compatte e aride. Dopo la fine della guerra solo una parte della ferrovia è stata ripristinata, e due binari funzionanti assicurano alcune corse al giorno.
E’ ancora buio, ma la stazione è già piena di gente.
Il convoglio che deve partire ha un carico piuttosto singolare: centinaia di bambini, scugnizzi per lo più, maschi e femmine dai sei ai dodici anni.
Paola è una di loro e di anni ne ha quasi sette, però ne dimostra di meno, tutta imbacuccata com’è nel cappotto troppo grande che le hanno dato le donne del Comitato. Si stropiccia gli occhi chiarissimi con le manine sporche lasciandosi due strisce nere sulla faccia smunta. “Tengo freddo ma’” dice per l’ennesima volta, tirando la gonna della madre che alza gli occhi al cielo, ma poi se la carica in braccio, coprendola col suo scialle. A lei il freddo si è depositato così infondo alle ossa che quasi non lo sente più. Si sistema la bimba al collo trattenendo una smorfia di dolore. I piedi, i piedi sono una piaga, a ogni passo sembra che decine di spilli si ficchino sotto le piante; “Fa’ la brava a mammà, su’” dice cercando di consolarla, “mo ti portano a Modena, ti danno il latte, il pane…”, continua cantilenante. Paola quella storia la sa a memoria, la mamma gliela ripete da un mese come fosse una favola.
Sprofonda la testa nello scialle, cerca quell’ odore familiare che sua madre ha sul collo, all’attaccatura dei capelli, un misto di canfora e limone che usa per sciacquarsi i capelli al posto del sapone che non c’è mai.
Michele cammina accanto a loro tutto intrizzito e silenzioso. I capelli rapati a zero per colpa dei pidocchi stanno ricrescendo come vellutino. Paola lo guarda. A vederlo ora, tutto spelacchiato, le dispiace di averlo preso in giro nei giorni scorsi. Lui continua a tirare su col naso, ma il muco ormai ha formato una scrosta cristallizzata attorno alla bocca. Si pulisce con un vecchio fazzoletto che tiene nella manica del cappotto, ma la crosta si riforma sempre.
Gaetano, un giovane uomo magro magro, con buffi occhialetti da intellettuale, comincia a fare l’appello: “…Capuano Mario”, si fa avanti un bimbo con lo sguardo basso “Di qua” dice l’uomo, spingendolo verso il primo vagone, “…Casolaro Rosa” continua con voce stentorea. Uno dopo l’altro sono divisi in modo che ad ogni gruppo corrisponda un vagone.
La radio nella cabina comandi, sintonizzata sul bollettino meteorologico, continua a prevedere mal tempo.
Paola si mette in coda con gli altri tenendo per mano Michele, che si gira in continuazione a guardare la madre. Ben presto sono tutti dentro, sistemati sui sedili di legno.
Il treno è quasi pronto a partire quando, da un vagone all’altro, si sente la stesso richiamo “e cappott!” e in men che non si dica tutti i bambini si tolgono il cappotto con la targhetta di riconoscimento faticosamente cucita dalle crocerossine su ogni capo, e lo lancia dai finestrini agli altri che rimangono, ai quali serve di più. Sono così veloci che la stazione si svuota in un attimo e non c’è più modo di recuperare le giacche. Sul treno hai voglia a chiedere i nomi vagone per vagone a tutti i bambini. Nessuno risponde! “Come ti chiami?” chiedono le donne del Comitato, ma i bimbi girano la faccia. Poi però portano il pane e le lingue cominciano a sciogliersi. “Io mi chiamo Giuseppe, Giuseppe Russo”, “Io Maria di Girolamo… c’ho così anni” dice un'altra aprendo la manina con le cinque dita allargate. Quando viene il suo turno, Paola dice il nome con un filo di voce che nessuno sente e Michele è costretto a ripeterlo lui. “Che begli occhi” dice la sorvegliante alzandole il mento con un dito, “più azzurri del cielo”. Paola abbassa con forza la faccia, perché è quello che le dice sempre sua madre.
Ci vogliono ore prima che, liste alla mano, riescano ad identificarli tutti ed a ricucire altre targhette numerate, stavolta direttamente sui vestiti. Quelli che proprio non vogliono parlare sono convinti con un trucco: “Antò’” gridano loro passando per i vagoni fino a che uno non si gira istintivamente sentendosi chiamare, “Allora si ttu Antonio!” e lo acchiappano al volo per cucirgli la targhetta. Gli ultimi due, un maschio e una femmina, sono identificati per esclusione. “Perché non ci volevi dire che ti chiamavi Ciro?” chiede una donna del comitato al bambino scontroso che non spiccicava una parola, “sei muto forse?”. Il ragazzino la guarda duro, “Aveva essere fesso a ddicere o nomme mio” risponde quello prima di richiudersi nel suo mutismo.
Finalmente il treno si muove e tutti si stringono l’un l’altro per farsi calore, mentre le donne passano tra i vagoni per portare coperte e parole di conforto.
Non piange nessuno, qualche bimbo al massimo si lamenta nel sonno.
Paola guarda il fratellino che tira su col naso, sonnacchioso. La mamma si è raccomandata di badare a lui finché resteranno insieme e lei combatte contro il sonno fino a che Michele, cullato dal dondolio del treno, non crolla tutto arrotolato come un gattino. Solo allora Paola chiude gli occhi e s’addormenta.
Si svegliarono a Reggio Emilia.
martedì 25 settembre 2007
venerdì 21 settembre 2007
La gara di mitto
Se solo ci ripenso adesso. Se solo ripenso a quanta vergogna ho provato, in quella lunghissima mezz’ora, vengo sopraffatta da una rabbia così profonda, da un tale rodimento di fegato, che nessun lasso di tempo potrà mai cancellare, nonostante la brillane laurea in psicologia e le pubblicazioni su Riza psicosomatica.
Lui e la sua maledettissima gara di mitto.
Quella mattina, l’insigne Professor Dottor Mastrangelo, vice-rettore della facoltà di medicina, esperto in neuropsichiatria infantile nonché presidente della mia commissione d’esame, m’aveva accolta con un espressione di arroganza e sufficienza da irritare una santa, figuriamoci io.
Ero riuscita a rimanere ferma, seduta, immobile davanti a lui senza mettermi a piangere, solo perché mi costringevo a concentrarmi sul suo parrucchino, di un osceno colore rossiccio, e il fatto che lui cadesse a pezzi, che era nella curva discendente della vita, mi dava un senso atavico di sicurezza.
“Allora signorina, mi parli di queste fasi”.
Ok. Calma e concentrazione. Le fasi. Le fasi le so. “Du… dunque” inizio balbettando, con la bocca così secca che neanche in pieno Sahara, “praticamente le fasi sono tre: orale, anale e fallica…”
“’Genitale è più corretto” mi corregge, “non succede solo ai maschietti”
Dice “maschietti”. Chi è che dice ancora “maschietti”? Ma che fa, sfotte?. M’impappino, immediatamente, “No, si, giusto, genitale, infatti… allora… praticamente…”, cerco di recuperare, “la prima si verifica nel neonato, che infatti tende a mettersi le dita in bocca e a mangiare qualsiasi cosa gli capita per le mani, la seconda è… praticamente…”
“Praticamente o teoricamente?” s’informa lui con un insopportabile aria da tuttologo, “la prego, si risparmi tutti questi inutili intercalari”, e io, “E… si, certo, dunque… allora… stavo dicendo…” Non mi ricordavo più quello che stavo dicendo.
“Parlavamo della fase anale” fa lui con un ghigno malefico stile stragatto.
Come è possibile che quest’uomo sia un medico e salvi esseri umani?, mi domandai mentre lui continuava a parlare, “Nella fase orale si trae piacere dall'incorporare, si sugge non solo per il bisogno di nutrirsi, ma anche per un desiderio di tipo sessuale…” disse lui calcando le parole “nella fase anale il bambino eroticizza altre parti… su, vada avanti…”
Io avevo la pianura padana nel cervello, e un unica domanda risplendeva al centro: Perché diavolo ho portato Freud?
Tormentandomi le mani sudaticce cerco di proseguire “Si, dunque… la seconda, la seconda fase è quella… quella…”
“Anale, lo abbiamo già detto” commenta lui con un espressione da psicotico.
“già… analeanale anale…” ripeto io imbambolata, come in quei giochi stupidi in cui ti fanno ripetere una parola che sembra senza senso tante volte di seguito fino a che non ti rendi conto che stai dicendo qualcosa di volgare tipo “ionico”.
La temperatura corporea mi era aumentata di circa tre gradi nel giro di due-tre secondi, un sudore sottile mi aveva ricoperto ovunque e mi cominciò a colare sulla schiena.
Era il mio esame di maturità, cazzo. Stava andando malissimo e in più parlavo di buchi di culo con un uomo più che adulto, un dottore porca miseria, che era lì per giudicarmi, con la bilancia del potere che pendeva inesorabilmente dalla sua parte.
“In questa seconda fase…” riprovai, cercando di pensare ad un qualsiasi sinonimo adatto. Consapevole di non riuscire a sopportare di nominare anche solo un'altra volta quel maledettissimo orfizio sul quale lo psichiatra ebreo aveva fondato metà delle sue teorie, “in questa seconda fase il bambino trova eccitante il momento in cui i genitori… in particolar modo quello di sesso opposto… insomma… stimola questa zona… per esempio… durante il cambio del pannolino… il bambino può addirittura avere l’istinto di mangiarsi le proprie feci… proprio per un’istintiva… ehm… ricerca del piacere”.
Oddioddioddio. Ho detto che mangiare merda è bello? Cerco di recuperare, “Freud descrive il neonato come un essere già capace, fin dai primi giorni di vita, di provare sensazioni erotiche, fino a circa i quattro anni d’età, dopo subisce una quiescenza fino alla pubertà… sposta l’attenzione…”
“Signorina, questo concetto è un po’ confuso, vuole essere più precisa, non so, fare qualche esempio?”
“Volevo dire che il bambino… insomma il bambino…” erano cose che sapevo benissimo, le avevo ripetute senza nessun problema, anche a mio padre, appena due giorni prima, porcamiseria.
“Forse vuole dire che trattenendo e rilasciando gli escrementi il bambino sensibilizza la zona anale e quella uretrale attivando un ulteriore fonte di piacere?”
“Si, proprio così, infatti…” mormoro io ormai del colore del ravanello.
“Signorina…”cercò il mio nome sul registro che aveva davanti, fece scorrere l’indice sull’elenco, lo trovò, “…signorina Onorato, non mi sembra molto preparata, non ha mai visto i ragazzi quando si mettono in fila e fanno a gara per vedere chi manda il mitto più lontano?”
“Il che?” feci io allibita, cercando di recuperare nella memoria qualcosa che mi indirizzasse verso una comprensione, se non proprio totale, per lo meno orientativa dell’argomento in questione.
Mitto mitto, pensavo frenetica, mitto, dal latino, mittere, emettere, lasciar andare, lanciare fuori, che cavolo è la gara del mitto porcaputtana?!
“Il mitto signorina, il getto, come lo chiama lei?” si spazientì lui “Quelle gare che fanno i ragazzini tra di loro. Non li ha mai visti?”
No, non li avevo mai visti, avrei dovuto rispondere. Avrei dovuto dire che i miei amici facevano a gara a chi ce lo aveva più lungo, a chi beveva più birre in una sola sera o magari a chi riusciva a farsi più ragazze in un estate, ma questa gara del mitto proprio non l’avevo mai vista né sentita, forse ai suoi tempi, avrei dovuto dire.
Quella notte sognai cinque Huckleberry Finn, col cappello di paglia in testa, le braghe calate e i pisellini in mano, che cercavano di superare con la piscia una linea fatta di legnetti. Io correvo avanti e indietro brandendo un metro da sarta.
Forse era a qualcosa del genere che si riferiva; non mi fu mai particolarmente chiaro, non lo fu per nessuno della commissione. Forse se lo era inventato solo per mettermi in difficoltà.
Mi diplomai con un tristissimo 41.
L’onta non fu mai lavata.
Lui e la sua maledettissima gara di mitto.
Quella mattina, l’insigne Professor Dottor Mastrangelo, vice-rettore della facoltà di medicina, esperto in neuropsichiatria infantile nonché presidente della mia commissione d’esame, m’aveva accolta con un espressione di arroganza e sufficienza da irritare una santa, figuriamoci io.
Ero riuscita a rimanere ferma, seduta, immobile davanti a lui senza mettermi a piangere, solo perché mi costringevo a concentrarmi sul suo parrucchino, di un osceno colore rossiccio, e il fatto che lui cadesse a pezzi, che era nella curva discendente della vita, mi dava un senso atavico di sicurezza.
“Allora signorina, mi parli di queste fasi”.
Ok. Calma e concentrazione. Le fasi. Le fasi le so. “Du… dunque” inizio balbettando, con la bocca così secca che neanche in pieno Sahara, “praticamente le fasi sono tre: orale, anale e fallica…”
“’Genitale è più corretto” mi corregge, “non succede solo ai maschietti”
Dice “maschietti”. Chi è che dice ancora “maschietti”? Ma che fa, sfotte?. M’impappino, immediatamente, “No, si, giusto, genitale, infatti… allora… praticamente…”, cerco di recuperare, “la prima si verifica nel neonato, che infatti tende a mettersi le dita in bocca e a mangiare qualsiasi cosa gli capita per le mani, la seconda è… praticamente…”
“Praticamente o teoricamente?” s’informa lui con un insopportabile aria da tuttologo, “la prego, si risparmi tutti questi inutili intercalari”, e io, “E… si, certo, dunque… allora… stavo dicendo…” Non mi ricordavo più quello che stavo dicendo.
“Parlavamo della fase anale” fa lui con un ghigno malefico stile stragatto.
Come è possibile che quest’uomo sia un medico e salvi esseri umani?, mi domandai mentre lui continuava a parlare, “Nella fase orale si trae piacere dall'incorporare, si sugge non solo per il bisogno di nutrirsi, ma anche per un desiderio di tipo sessuale…” disse lui calcando le parole “nella fase anale il bambino eroticizza altre parti… su, vada avanti…”
Io avevo la pianura padana nel cervello, e un unica domanda risplendeva al centro: Perché diavolo ho portato Freud?
Tormentandomi le mani sudaticce cerco di proseguire “Si, dunque… la seconda, la seconda fase è quella… quella…”
“Anale, lo abbiamo già detto” commenta lui con un espressione da psicotico.
“già… analeanale anale…” ripeto io imbambolata, come in quei giochi stupidi in cui ti fanno ripetere una parola che sembra senza senso tante volte di seguito fino a che non ti rendi conto che stai dicendo qualcosa di volgare tipo “ionico”.
La temperatura corporea mi era aumentata di circa tre gradi nel giro di due-tre secondi, un sudore sottile mi aveva ricoperto ovunque e mi cominciò a colare sulla schiena.
Era il mio esame di maturità, cazzo. Stava andando malissimo e in più parlavo di buchi di culo con un uomo più che adulto, un dottore porca miseria, che era lì per giudicarmi, con la bilancia del potere che pendeva inesorabilmente dalla sua parte.
“In questa seconda fase…” riprovai, cercando di pensare ad un qualsiasi sinonimo adatto. Consapevole di non riuscire a sopportare di nominare anche solo un'altra volta quel maledettissimo orfizio sul quale lo psichiatra ebreo aveva fondato metà delle sue teorie, “in questa seconda fase il bambino trova eccitante il momento in cui i genitori… in particolar modo quello di sesso opposto… insomma… stimola questa zona… per esempio… durante il cambio del pannolino… il bambino può addirittura avere l’istinto di mangiarsi le proprie feci… proprio per un’istintiva… ehm… ricerca del piacere”.
Oddioddioddio. Ho detto che mangiare merda è bello? Cerco di recuperare, “Freud descrive il neonato come un essere già capace, fin dai primi giorni di vita, di provare sensazioni erotiche, fino a circa i quattro anni d’età, dopo subisce una quiescenza fino alla pubertà… sposta l’attenzione…”
“Signorina, questo concetto è un po’ confuso, vuole essere più precisa, non so, fare qualche esempio?”
“Volevo dire che il bambino… insomma il bambino…” erano cose che sapevo benissimo, le avevo ripetute senza nessun problema, anche a mio padre, appena due giorni prima, porcamiseria.
“Forse vuole dire che trattenendo e rilasciando gli escrementi il bambino sensibilizza la zona anale e quella uretrale attivando un ulteriore fonte di piacere?”
“Si, proprio così, infatti…” mormoro io ormai del colore del ravanello.
“Signorina…”cercò il mio nome sul registro che aveva davanti, fece scorrere l’indice sull’elenco, lo trovò, “…signorina Onorato, non mi sembra molto preparata, non ha mai visto i ragazzi quando si mettono in fila e fanno a gara per vedere chi manda il mitto più lontano?”
“Il che?” feci io allibita, cercando di recuperare nella memoria qualcosa che mi indirizzasse verso una comprensione, se non proprio totale, per lo meno orientativa dell’argomento in questione.
Mitto mitto, pensavo frenetica, mitto, dal latino, mittere, emettere, lasciar andare, lanciare fuori, che cavolo è la gara del mitto porcaputtana?!
“Il mitto signorina, il getto, come lo chiama lei?” si spazientì lui “Quelle gare che fanno i ragazzini tra di loro. Non li ha mai visti?”
No, non li avevo mai visti, avrei dovuto rispondere. Avrei dovuto dire che i miei amici facevano a gara a chi ce lo aveva più lungo, a chi beveva più birre in una sola sera o magari a chi riusciva a farsi più ragazze in un estate, ma questa gara del mitto proprio non l’avevo mai vista né sentita, forse ai suoi tempi, avrei dovuto dire.
Quella notte sognai cinque Huckleberry Finn, col cappello di paglia in testa, le braghe calate e i pisellini in mano, che cercavano di superare con la piscia una linea fatta di legnetti. Io correvo avanti e indietro brandendo un metro da sarta.
Forse era a qualcosa del genere che si riferiva; non mi fu mai particolarmente chiaro, non lo fu per nessuno della commissione. Forse se lo era inventato solo per mettermi in difficoltà.
Mi diplomai con un tristissimo 41.
L’onta non fu mai lavata.
giovedì 20 settembre 2007
scrivo
Un bel giorno, un uomo con splendidi baffi biondi mi ha detto – Io voglio fare il regista -.
Ha detto subito così, deciso.
Ho pensato che fosse molto affascinante, come se avesse detto astronauta o ballerina, considerando cinicamente la stessa vaga probabilità di riuscita.
Qualche sera dopo, in una scenografia a lume di candela, su un letto con lenzuola rosso-bordò, ha mormorato rapito “Sei bella su questo colore”.
“Cazzo, regista dentro” ho pensato io.
Mi sono resa conto allora che lui faceva sul serio, o quanto meno si comportava come se lo fosse veramente, ci credeva, aveva la direzione giusta, l’atteggiamento adatto.
Io voglio fare il regista.
Io voglio fare.
Io voglio.
Io.
Mi sono vergognata tremendamente.
Io, al contrario, mi nascondo spesso, mi distraggo sempre, mi lascio distogliere, non dico, non sono poi così sicura.
Visualizzo il tempo e il talento sperperati in torrette di smemoranda fitte fitte, come se fosse impossibile ancora prima d’iniziare. Senza coraggio.
Da ragazza era sempre la stessa storia Parli come un libro stracciato, Non metti i soggetti, Non ti seguo più, Ti spieghi una vera merda e io giù a citare Gibran La metà di quello che dico è incomprensibile, ma la dico affinché l’altra metà arrivi pura e cristallina.
Non è cambiato molto da allora. La mia difficoltà è rimasta più o meno la stessa. Non riesco a spiegarmi bene, a decidere in fretta, m’incarto mentre parlo, faccio gravi errori d’ortografia, mi invento le cose, sfuggo le responsabilità, me ne fotto. Sempre stata una bambina di otto anni, dieci forse.
Eppure ci ho provato, a distrarmi dall’idea, per tempi lunghissimi non l’ho considerata neanche una possibilità realistica Ma chi ti credi di essere?
Lo giuro c’ho provato, a sostenere progetti che mi sembravano più interessanti, utili, divertenti, socializzanti, concreti, coerenti. Ci provo sempre, a tenere a bada la mia natura. Lei non è proprio dolce, attenta, accondiscendente come me, è più irresponsabile, egocentrica, pericolosa, ingenua, feroce. Una bambina, che vergogna.
Posso fare la fidanzata, la figlia, la collega, l’altra parte della mela, l’anello mancante, la parte utile, ma voglio prima di tutto scrivere in pace.
Virginia Woolf ha ragione, serve una stanza tutta per se e io pensavo di non poterla avere Non scriverò mai niente che valga la pena di essere letto. Forse non l’ho mai cercata veramente (la vergogna aumenta in maniera esponenziale).
Vado dappertutto e mi sento sempre di passaggio. Che cosa ho che non va? Perché mi ritrovo sempre con le gambe che sprofondano lentamente nelle sabbie mobili di interessantissimi progetti che non sono per me?
Sono miope, ma non porto gli occhiali. Ho sempre letto con luce scarsissima, da sola, quando avrei dovuto/potuto dormire; ed ho sempre scritto dappertutto, anche su treni e aerei, in macchina col mal di mare, per strada. Se non c’è il computer a matita, preferisco, anche se è l’unica scripta che non manent, non importa; lo faccio da sempre, da quando mi ricordo, mangiucchiando, dopo aver scopato, mentre piango.
In 4° elementare scrissi una poesia in rima baciata intitolata La spilla Camomilla. Narrava rocambolesche avventure di una sfortunata spilletta da balia.
La declamai con enfasi alla mia amichetta del cuore, durante l’intervallo, e ridemmo tanto da pisciarci addosso. La cosa ci fece ridere ancora di più, faticammo a smettere.
Per ovviare al problema scappammo in bagno, ci togliemmo le mutandine bagnate e le nascondemmo, chiuse in un sacchetto di plastica, ovviamente nella mia cartella perché ero io la più disordinata.
Rimanemmo in uno stato di felicità totale per l’intera giornata, ridacchiando in continuazione, ripetendoci a memoria i passaggi più buffi e prendendo strilli in testa dalle maestre. Quel giorno eravamo state invitate a pranzo a casa di una nostra amica e dopo mangiato le svelammo il segreto. Lei si scandalizzò così tanto che volle assolutamente prestarcene due delle sue. Quella che mi diede la conservo ancora, come monito Non si può andare in giro senza mutande, non si fa, e basta.
Mio padre una volta ha detto Pensa alla grande, me lo ricordo ancora. Dice cose del tipo Ginger Rogers faceva le stesse cose di Fred Astaire, ma con la gonna e con i tacchi a spillo, quando poi gli ho spiegato che lo stavo facendo e anche per questo mi ero licenziata, ha sfregato pollice ed indice insieme come a dire “e i soldi?”.
Mia madre, invece, è una donna manualmente molto abile, brava a disegnare, lavora la ceramica, crea forme. Dopo che io per anni ho evitato come la peste il suo laboratorio, ho sentito che diceva di me a qualcuno “E’ un’artigiana della testa, non delle mani”, come a giustificarmi, e la cosa non mi è dispiaciuta.
Forse voleva dire che sono una di quelle che magari non te lo dimostra, però magari te lo scrive.
Comunque la prima e unica volta che mi hanno pagato in soldoni una stronzata di articolo mi sono sentita una grande, anche se l’euforia è durata poco, il tempo di consumare i soldi. Però ha fatto capolino un po’ di orgoglio.
Tutto diventa più potente, è come una folgorazione, un cerchio che si chiude.
Quando fomento il mio lato tragico sono una di quelle a cui piace farsi un po’ male, una fancazzista, anche.
Il nodo in gola ogni tanto c’è ancora, ma finalmente posso prendermi per il culo, tirarmela a pazzi, mettere “Scrittrice” nello spazio dove c’è da indicare “Professione” (come se scrivere fosse un lavoro).Ancora fatico un po’ a prendermi sul serio, l’imbarazzo c’è ancora, il disagio non è vinto, ma io scrivo.
Ha detto subito così, deciso.
Ho pensato che fosse molto affascinante, come se avesse detto astronauta o ballerina, considerando cinicamente la stessa vaga probabilità di riuscita.
Qualche sera dopo, in una scenografia a lume di candela, su un letto con lenzuola rosso-bordò, ha mormorato rapito “Sei bella su questo colore”.
“Cazzo, regista dentro” ho pensato io.
Mi sono resa conto allora che lui faceva sul serio, o quanto meno si comportava come se lo fosse veramente, ci credeva, aveva la direzione giusta, l’atteggiamento adatto.
Io voglio fare il regista.
Io voglio fare.
Io voglio.
Io.
Mi sono vergognata tremendamente.
Io, al contrario, mi nascondo spesso, mi distraggo sempre, mi lascio distogliere, non dico, non sono poi così sicura.
Visualizzo il tempo e il talento sperperati in torrette di smemoranda fitte fitte, come se fosse impossibile ancora prima d’iniziare. Senza coraggio.
Da ragazza era sempre la stessa storia Parli come un libro stracciato, Non metti i soggetti, Non ti seguo più, Ti spieghi una vera merda e io giù a citare Gibran La metà di quello che dico è incomprensibile, ma la dico affinché l’altra metà arrivi pura e cristallina.
Non è cambiato molto da allora. La mia difficoltà è rimasta più o meno la stessa. Non riesco a spiegarmi bene, a decidere in fretta, m’incarto mentre parlo, faccio gravi errori d’ortografia, mi invento le cose, sfuggo le responsabilità, me ne fotto. Sempre stata una bambina di otto anni, dieci forse.
Eppure ci ho provato, a distrarmi dall’idea, per tempi lunghissimi non l’ho considerata neanche una possibilità realistica Ma chi ti credi di essere?
Lo giuro c’ho provato, a sostenere progetti che mi sembravano più interessanti, utili, divertenti, socializzanti, concreti, coerenti. Ci provo sempre, a tenere a bada la mia natura. Lei non è proprio dolce, attenta, accondiscendente come me, è più irresponsabile, egocentrica, pericolosa, ingenua, feroce. Una bambina, che vergogna.
Posso fare la fidanzata, la figlia, la collega, l’altra parte della mela, l’anello mancante, la parte utile, ma voglio prima di tutto scrivere in pace.
Virginia Woolf ha ragione, serve una stanza tutta per se e io pensavo di non poterla avere Non scriverò mai niente che valga la pena di essere letto. Forse non l’ho mai cercata veramente (la vergogna aumenta in maniera esponenziale).
Vado dappertutto e mi sento sempre di passaggio. Che cosa ho che non va? Perché mi ritrovo sempre con le gambe che sprofondano lentamente nelle sabbie mobili di interessantissimi progetti che non sono per me?
Sono miope, ma non porto gli occhiali. Ho sempre letto con luce scarsissima, da sola, quando avrei dovuto/potuto dormire; ed ho sempre scritto dappertutto, anche su treni e aerei, in macchina col mal di mare, per strada. Se non c’è il computer a matita, preferisco, anche se è l’unica scripta che non manent, non importa; lo faccio da sempre, da quando mi ricordo, mangiucchiando, dopo aver scopato, mentre piango.
In 4° elementare scrissi una poesia in rima baciata intitolata La spilla Camomilla. Narrava rocambolesche avventure di una sfortunata spilletta da balia.
La declamai con enfasi alla mia amichetta del cuore, durante l’intervallo, e ridemmo tanto da pisciarci addosso. La cosa ci fece ridere ancora di più, faticammo a smettere.
Per ovviare al problema scappammo in bagno, ci togliemmo le mutandine bagnate e le nascondemmo, chiuse in un sacchetto di plastica, ovviamente nella mia cartella perché ero io la più disordinata.
Rimanemmo in uno stato di felicità totale per l’intera giornata, ridacchiando in continuazione, ripetendoci a memoria i passaggi più buffi e prendendo strilli in testa dalle maestre. Quel giorno eravamo state invitate a pranzo a casa di una nostra amica e dopo mangiato le svelammo il segreto. Lei si scandalizzò così tanto che volle assolutamente prestarcene due delle sue. Quella che mi diede la conservo ancora, come monito Non si può andare in giro senza mutande, non si fa, e basta.
Mio padre una volta ha detto Pensa alla grande, me lo ricordo ancora. Dice cose del tipo Ginger Rogers faceva le stesse cose di Fred Astaire, ma con la gonna e con i tacchi a spillo, quando poi gli ho spiegato che lo stavo facendo e anche per questo mi ero licenziata, ha sfregato pollice ed indice insieme come a dire “e i soldi?”.
Mia madre, invece, è una donna manualmente molto abile, brava a disegnare, lavora la ceramica, crea forme. Dopo che io per anni ho evitato come la peste il suo laboratorio, ho sentito che diceva di me a qualcuno “E’ un’artigiana della testa, non delle mani”, come a giustificarmi, e la cosa non mi è dispiaciuta.
Forse voleva dire che sono una di quelle che magari non te lo dimostra, però magari te lo scrive.
Comunque la prima e unica volta che mi hanno pagato in soldoni una stronzata di articolo mi sono sentita una grande, anche se l’euforia è durata poco, il tempo di consumare i soldi. Però ha fatto capolino un po’ di orgoglio.
Tutto diventa più potente, è come una folgorazione, un cerchio che si chiude.
Quando fomento il mio lato tragico sono una di quelle a cui piace farsi un po’ male, una fancazzista, anche.
Il nodo in gola ogni tanto c’è ancora, ma finalmente posso prendermi per il culo, tirarmela a pazzi, mettere “Scrittrice” nello spazio dove c’è da indicare “Professione” (come se scrivere fosse un lavoro).Ancora fatico un po’ a prendermi sul serio, l’imbarazzo c’è ancora, il disagio non è vinto, ma io scrivo.
Iscriviti a:
Post (Atom)